Se Dio esistesse davvero ma nessuno ne avesse mai parlato ad altri, quanti ci crederebbero?
I credenti non credono in Dio (o negli dèi): suona provocatorio, quasi un paradosso, ma è esattamente la tesi con la quale Dario chiude questa trilogia critica sulla religione. Chi dice di credere in Dio crede in realtà a ciò che altri esseri umani hanno raccontato su Dio.
Fin dall’infanzia ci viene narrata una storia: esiste un Essere supremo che ha fatto questo e quello, ha dettato regole, ha compiuto prodigi e ha scritto o ispirato libri sacri. Ma di quella storia noi conosciamo solo le parole di altri esseri umani. Nessuno di noi ha mai ricevuto il manoscritto autografo di Dio né una telefonata dall’Aldilà. Abbiamo ascoltato dei racconti, letto dei testi antichi, partecipato a dei rituali inventati da esseri umani. Abbiamo creduto a loro. In poche parole: il credente medio non ha fede in Dio in quanto tale bensì in una tradizione umana che parla di Dio.
Pensiamoci bene: tutte le informazioni che un fedele possiede sulla propria divinità provengono da fonti umane. Bibbie, Vangeli, Corani, Veda, Sutra, testi di ogni religione: opere di esseri umani. Prediche, catechismi, tradizioni orali: trasmissione umana. Anche quelle che chiamiamo «rivelazioni» divine sono sempre rivelazioni fatte a qualcuno che poi le racconta a tutti gli altri: Mosè sostiene che Dio gli ha parlato da un roveto ardente, Paolo riferisce di aver udito la voce di Cristo sulla via di Damasco, Maometto dichiara che l’arcangelo Gabriele gli ha dettato il Corano. Noi non eravamo lì. Noi abbiamo solo la loro parola. In pratica ai credenti si chiede: «Credi a me che ti riferisco che cosa dice Dio». È un gigantesco telefono senza filo teologico, che parte da un presunto messaggero divino e arriva fino a noi dopo millenni di passaparola.
La fede nei racconti (e in chi li racconta)
La costruzione della fede si basa dunque su una fiducia accordata a testimoni umani. Il credente si fida degli autori dei testi sacri e dei custodi della tradizione. Non crede in Dio come realtà riscontrabile, ma crede al racconto che gli è stato fatto su Dio. È una distinzione sottile ma fondamentale: se tutti quei racconti fossero un inganno o un errore, la fede crollerebbe, indipendentemente dall’eventuale esistenza di qualche divinità. In altri termini: se Dio esistesse davvero ma nessuno ne avesse mai parlato ad altri, quanti ci crederebbero? Nessuno. La fede vive di narrazioni.
Un musulmano crede che Maometto abbia ricevuto il Corano dall’arcangelo Gabriele perché si fida di ciò che dice la tradizione islamica. Un cristiano crede che Gesù sia risorto perché accetta per buona la testimonianza dei Vangeli. Un mormone crede alle visioni di Joseph Smith sui dischi d’oro perché dà credito alle parole di Smith. E così via. Ognuno crede a qualcuno. O meglio: crede al racconto tramandato da qualcuno. Il paradosso è che ogni fedele riconosce facilmente la natura umana mitologica delle religioni altrui: il cristiano è convinto che le storie di Zeus o di Vishnu siano solo miti inventati, il musulmano ritiene falsi o corrotti i Vangeli cristiani, l’ebreo rifiuta il Nuovo Testamento e il Corano, l’ateo li rifiuta tutti. Insomma ognuno è scettico sugli dèi altrui, liquidandoli come fantasie o falsità. Ciò che il credente non fa quasi mai è applicare lo stesso scetticismo al proprio credo: non considera i propri testi sacri come storie inventate da esseri umani, anche se in effetti lo sono tanto quanto gli altri.
Qui sorge la domanda cruciale: chi ci assicura che proprio la nostra tradizione religiosa, tra centinaia di tradizioni contraddittorie, sia quella autenticamente ispirata da Dio? La risposta sincera sarebbe disarmante: nessuno, se non i custodi stessi di quella tradizione. In pratica crediamo che «la Bibbia è parola di Dio» perché la Bibbia stessa lo afferma o perché ce lo dice il prete, crediamo che «il Corano è disceso dal cielo» perché il Corano stesso lo dice o perché ce lo assicura l’imam. È un circolo chiuso: il racconto garantisce sé stesso. Un po’ poco dal punto di vista logico, no? È come se io scrivessi un libro sostenendo di essere il profeta di una nuova divinità e, se qualcuno dubitasse, replicassi: «È tutto vero, lo giuro sul mio libro!». Un ragionamento tautologico che non dimostrerebbe nulla, se non la mia faccia tosta.
Già nell’Ottocento Ludwig Feuerbach lo affermava senza mezzi termini: le divinità sono proiezioni dell’essere umano, creature della nostra fantasia collettiva.
Non è Dio ad aver creato l’uomo, ma è l’uomo ad aver creato Dio.
– Ludwig Feuerbach
Gli esseri umani hanno attribuito a un ente immaginario tutte le qualità straordinarie che essi vorrebbero avere (perfezione, immortalità, onnipotenza) e poi si sono inginocchiati davanti alla propria creazione. Questo concetto era stato intuito, in modo ancora più ironico, già 2500 anni fa dal filosofo greco Senofane: notò che gli Etiopi raffiguravano gli dèi come uomini neri e con il naso camuso, mentre i Traci li dipingevano con occhi azzurri e capelli rossi, insomma ciascuno a propria immagine. Senofane arrivò a dire che, se cavalli e buoi avessero mani per disegnare, disegnerebbero i propri dèi simili a cavalli e buoi. In poche parole, ogni popolo – perfino ogni specie – si crea un dio a propria somiglianza, riflesso dei propri desideri e del proprio immaginario. Quando poi questi dèi vengono narrati nelle leggende e fissati nei libri, acquistano «vita» nella mente delle persone, che iniziano a credere che il racconto sia realtà.
Credere in Dio significa quindi molto spesso credere ai narratori di Dio. Si crede a Mosè, a Paolo di Tarso, a Maometto, a Joseph Smith, al guru di turno o al teologo interprete. Si sposa la narrazione che costoro propongono. E attenzione: questo non avviene solo nella religione, ma in ogni ambito in cui accettiamo qualcosa per vero senza verificarlo di persona. La differenza è che per Babbo Natale o l’oroscopo prima o poi cresce in noi il sospetto che siano favolette, invece per la religione quel sospetto viene soffocato sul nascere dalla solennità della tradizione e dal fatto che milioni di persone ci credono da millenni. Come se l’antichità e il successo di una storia la rendessero automaticamente vera: un evidente errore logico, ma assai persuasivo sul piano psicologico.
Piramidi, oggetti magici e dèi inventati: un esempio analogico
Cerchiamo di illustrare il concetto con un esempio analogico e ironico. Immaginiamo un futuro lontano: poniamo l’anno 5000. Della nostra civiltà attuale è rimasto poco: molte conoscenze sono andate perdute in guerre e cataclismi, e l’umanità è regredita tecnologicamente. I nuovi abitanti della Terra scoprono, semisepolte nelle sabbie d’Egitto, delle enormi costruzioni di pietra dalla forma insolita. Ritrovano le piramidi, ma non sanno nulla degli antichi faraoni né dell’ingegneria con cui furono costruite. Quegli enormi edifici appaiono ai loro occhi come opere ultraterrene, impossibili da realizzare per mano umana. Nascono così delle leggende: c’è chi sostiene che siano state erette dagli dèi discesi dal cielo, chi invece le ritiene portali verso un altro mondo. Un gruppo di abili affabulatori si autoproclama detentore della verità: «Gli dèi ci hanno lasciato le piramidi come prova del loro potere. Un tempo essi regnavano sul mondo e in futuro torneranno». Questi sedicenti sapienti scrivono nuovi testi sacri dove raccontano che sotto la Grande piramide dorme un oggetto soprannaturale, un «cuore di cristallo» capace di guarire ogni male, dono dei signori celesti. La gente, affascinata e intimorita, inizia a crederci. Si formano dei culti: folle di fedeli compiono pellegrinaggi alle piramidi, portano offerte, pregano gli dèi perché un giorno riemergano con il loro carico di miracoli. Con il passare delle generazioni, questa credenza si consolida. Milioni di persone venerano le Piramidi sacre. Credono davvero negli dèi delle piramidi? Se lo chiedi a loro, ti diranno di sì. In realtà credono in ciò che altri esseri umani hanno raccontato riguardo a quegli dèi. Nessuno di loro ha mai visto gli dèi costruire alcunché, nessuno ha mai trovato il favoloso «cuore di cristallo» nascosto. (Qualcuno dirà che è invisibile agli impuri, ovviamente.) La loro fede è tutta riposta in un racconto: il racconto sulle origini divine di quelle misteriose costruzioni. Hanno preso un manufatto reale ma inspiegabile (le piramidi) e gli hanno ricamato attorno una storia mitica per appagare il bisogno di senso e di meraviglia.
Questo mio esempio fantasioso in fondo non è diverso da ciò che è davvero accaduto nella Storia. Pensiamo a quante opere umane sono state attribuite agli dèi. I fulmini? «È Giove», dicevano i Romani. Le altissime mura di Troia? «Le hanno costruite Apollo e Poseidone», recitava il mito greco. I tuoni? «È il dio Thor che sta combattendo», secondo i Vichinghi. Ogni volta che qualcosa appariva straordinario o incomprensibile, la spiegazione immediata era inventare un racconto divino. Oggi sorridiamo di quelle mitologie, le cataloghiamo come leggende. Ma il meccanismo mentale è rimasto lo stesso.
Non serve andare nel futuro: guardiamo un esempio nel passato recente, realmente accaduto. Durante la Seconda guerra mondiale alcune popolazioni isolate del Pacifico videro arrivare dal cielo gli aerei americani carichi di rifornimenti. Quegli indigeni non avevano mai visto la tecnologia moderna: interpretarono quei «grandi uccelli di metallo» come manifestazioni divine. Nacquero i cargo cult, culti religiosi in cui si veneravano figure come John Frum, una sorta di messia venuto dal cielo con doni, che in realtà erano i cargo dei soldati. In assenza di spiegazioni comprensibili, hanno creato dal nulla una narrazione sacra per dare senso a ciò che vedevano. Hanno costruito altari, rituali, perfino riproduzioni di aerei fatte di legno, sperando di attirare di nuovo i doni celesti. Questa storia è vera e documentata: è bastato un evento inspiegabile a innescare la nascita di una mini-religione nel giro di pochi anni, per pura opera della fantasia umana.
Se in pochi decenni un gruppo di tribù può convincersi dell’esistenza di un messia dei cargo, che cosa possono aver costruito millenni di tradizioni religiose stratificate? Quante analoghe leggende sono fiorite attorno a fatti reali ma fraintesi o magari attorno a nulla di reale se non la voce di un predicatore carismatico? La venerazione delle reliquie, per esempio, ha portato persone razionali a credere che un pezzo di osso o un frammento di legno possedesse poteri miracolosi, solo perché qualcuno l’aveva spacciato per «osso di un santo» o «legno della croce di Cristo». In epoca medievale circolavano così tanti chiodi «autentici» della croce di Gesù che a metterli insieme ci si poteva costruire un veliero e ciascuno era venerato come sacro grazie alla storia raccontata su di esso. Analogamente molti cercarono la mitica pietra filosofale perché i testi alchemici ne narravano i prodigi, senza che nessuno l’avesse mai vista davvero. Ancora oggi c’è chi crede agli «antichi astronauti» – l’idea che alieni avanzati abbiano costruito le piramidi, Stonehenge e altre meraviglie – preferendo una narrazione fantascientifica alla più semplice realtà dell’ingegno e della fatica umani. Insomma cambiano i contesti ma la tendenza resta: invece di dire «Non lo so», alcuni esseri umani inventano una storia. E altri esseri umani finiscono col crederci.
Profezie vaghe, mancate e postdatate
Un elemento affascinante che accomuna molte narrazioni religiose è la presenza di profezie. Cosa c’è di meglio, per sostenere che un racconto proviene da Dio, che inserire al suo interno qualche spettacolare previsione del futuro? Se si avvera, evviva, sarà la prova che l’ispirazione era divina. Se non si avvera… be’, si troverà il modo di giustificarla o di reinterpretarla. In effetti, esaminando con occhio critico le profezie presenti nei testi sacri, scopriamo un quadro desolante: le poche che sono specifiche non si sono realizzate, e quelle che si possono far passare per realizzate sono talmente generiche o ambigue che ci vuole più fede per vederle esaudite di quanta ne serva per credere ai tarocchi.
Prendiamo il caso del cristianesimo. Nei Vangeli Gesù pronuncia una famosa profezia apocalittica: parla ai suoi discepoli del Regno di Dio e del giudizio finale e conclude dicendo
«Io vi assicuro che non passerà questa generazione prima che queste cose siano accadute.
– Matteo 24,34
Hai capito bene: prometteva la fine dei tempi entro la generazione dei suoi ascoltatori, dunque nel I secolo d.C. O ancora, in un altro passo, dice:
Io vi assicuro che alcuni tra quelli che sono qui presenti non moriranno prima di aver visto venire il Figlio dell’uomo e il suo regno».
– Matteo 16,28
Parole chiarissime, eppure sono passati quasi due millenni e del regno escatologico nessuna traccia. Quella generazione è morta da un pezzo, e molte altre dopo di essa. Si tratta dunque di una profezia non avverata, un falso allarme. Naturalmente i teologi si sono arrampicati sugli specchi per rileggerla in altro modo: c’è chi sostiene che Gesù in realtà si riferisse a eventi simbolici, chi che parlasse della distruzione di Gerusalemme avvenuta nel 70 d.C., un evento drammatico ma ben lontano dall’instaurazione del Regno di Dio per tutti i popoli. Resta il fatto che, presa nel suo senso più immediato, quella predizione è risultata falsa. E con essa sono fallite le aspettative apocalittiche dei primi cristiani: gli Atti degli Apostoli e le Lettere di Paolo mostrano una comunità convinta che la seconda venuta di Cristo fosse imminente. Paolo scrive ai Corinzi:
Fratelli, io vi dico questo: è poco il tempo che ci rimane.
– 1 Corinzi 7,29
Inoltre consiglia loro di non sposarsi nemmeno, ché tanto il mondo presente sta per finire. Evidentemente anche lui si aspettava di veder calare il sipario entro la sua epoca. Sappiamo com’è andata a finire: il sipario non è calato affatto e il «ritorno di Cristo» è stato rimandato sine die.
Questa tendenza a prevedere una fine imminente e a essere smentiti dai fatti non è solo biblica: ha attraversato tutta la storia della cristianità e non solo. Basti pensare alle innumerevoli sette millenaristiche che, interpretando a modo proprio le Scritture, hanno annunciato date precise per la fine del mondo o per l’avvento di un’era messianica: dai montanisti nel II secolo fino ai profeti moderni. I Testimoni di Geova per esempio indicarono prima il 1914 come data dell’Armageddon, poi, visto che il mondo inspiegabilmente continuava a esistere, spostarono la previsione più in là (1918, 1925, 1975…), ogni volta trovando masse di credenti pronti a crederci. Naturalmente ogni volta, al mancato avverarsi, la profezia veniva «reinterpretata» o si spiegava il fatto con un equivoco. Ormai queste date disattese sono talmente tante che fanno sorridere, eppure c’è chi ancora riesce a non perdere la fede, purché qualcuno confezioni una nuova spiegazione narrativa in cui incasellare il flop precedente.
Non che le altre religioni monoteiste stiano meglio sul fronte delle profezie. Nell’Islam primitivo, molti compagni di Maometto pensavano che l’Ora del Giudizio sarebbe arrivata presto anche per loro: alcuni hadith (tradizioni orali) riportano frasi del Profeta che lasciano intendere un giudizio imminente. Ad esempio si narra che Maometto disse «La vita di questo mondo non durerà oltre cento anni a partire da ora»: una frase interpretata come «entro un secolo sarà arrivata la fine dei tempi». I commentatori moderni si affrettano a dire che Maometto intendeva solo che «nessuno dei presenti sarà vivo tra cent’anni» – una banalità ovvia –, ma il dubbio che volesse alimentare l’attesa escatologica resta. Del resto anche il Corano descrive segni premonitori dell’Ora (come lo «splendore» o spaccatura della Luna) che i musulmani dei primi tempi credevano di vedere già all’orizzonte. Passati 1400 anni, l’escatologia islamica è stata aggiornata spostando la lancetta in avanti, esattamente come è accaduto nel cristianesimo.
Ci sono poi le profezie generiche, quelle che non possono mai essere smentite perché sono abbastanza vaghe da adattarsi a qualsiasi evento. È la tecnica classica di astrologi e chiaroveggenti: annunciare che «ci saranno guerre e carestie e segni nei cieli e grandi tumulti», cioè eventi che, in un modo o nell’altro, si verificano in ogni generazione. Molti testi sacri abbondano di profezie di questo tipo. L’Apocalisse di Giovanni, ad esempio, parla per enigmi e simboli: draghi, trombe, cavalli pallidi e coppe dell’ira, in un caleidoscopio visionario che può significare tutto e niente. In ogni secolo c’è chi rilegge l’Apocalisse pensando che descriva proprio gli eventi del suo tempo: così ai tempi di Napoleone si identificava lui con l’Anticristo, durante la Guerra Fredda il «drago» era ora l’Unione Sovietica ora la Cina, oggi magari qualcuno ci vede l’ombra di qualche potenza contemporanea. Insomma la profezia diventa un eterno vestito di Arlecchino, rattoppato e colorato a seconda di chi lo indossa. Ma di concreto non c’è nulla.
Le profezie mancanti o fallite e quelle realizzate solo a posteriori – con l’escamotage di dire «Oh, ecco, questo evento avvenuto oggi combacia con quella frase oscura scritta secoli fa!» – rivelano la matrice umana di questi racconti. Se davvero esistesse un Dio onnisciente che rivela il futuro ai suoi portavoce, perché queste predizioni sono così nebulose o inaccurate? Perché l’Onnipotente dovrebbe parlare come l’oracolo di Delfi, in modo contorto, lasciando che i suoi seguaci brancolino nell’incertezza o si illudano invano? Più credibile, purtroppo, è l’ipotesi che siano stati esseri umani a scrivere queste profezie, magari autoconvinti di parlare per conto divino oppure con l’astuto scopo di suggestionare i posteri. Gli autori biblici del passato potevano contare sul fatto che, una volta trascorsi secoli, i lettori avrebbero fatto equilibrismi interpretativi pur di mantenere intatta la credenza nella sacralità del testo. E così è stato. Ma chi osserva dall’esterno, con occhio critico, vede il trucco: tutte le religioni hanno profezie non avverate nel loro bagaglio, e tutte trovano il modo di scusarle o di dimenticarle. Si crede al racconto più che ai fatti. Meglio piegare i fatti – o ignorarli – che ammettere che il racconto sacro possa contenere errori. D’altronde, se crolla la fiducia nel racconto, crolla la fede. E allora vai di fantasia per accomodare la realtà alla profezia, mentre dovrebbe essere il contrario.
A ben vedere, la differenza tra le profezie religiose e le famose quartine di Nostradamus è solo nel contesto: le seconde sono pubblicate in un almanacco esoterico, le prime in un libro considerato sacro. Ma il modus operandi è simile. Nostradamus scrisse versi criptici che chiunque può tirare da una parte o dall’altra a piacimento: c’è chi crede che avesse predetto Napoleone, Hitler, l’11 settembre, le guerre mondiali, semplicemente perché dopo questi eventi ci si è messi a cercare frasi vagamente compatibili nelle sue sestine. Nessuno però riesce a predire prima qualcosa di utile basandosi su Nostradamus, ovviamente. Eppure tanti ci credono. Con le profezie bibliche o coraniche succede la stessa cosa: si legge il presente come «profezia realizzata» di qualche versetto di 2000 anni fa, ma quei testi non servono mai a prevedere con anticipo e chiarezza qualcosa. Servono solo a rileggere il passato con la lente della conferma. È un gioco di prestigio narrativo: aggiustiamo la storia per far sembrare che il nostro libro sacro avesse ragione e continuiamo a crederci.
L’arguzia di Voltaire calza a pennello: «Chi riesce a farvi credere assurdità può farvi commettere atrocità». La storia è piena di esempi di atrocità commesse in nome di profezie o di dottrine religiose indimostrabili. Ma, senza andare agli estremi, basterà dire: chi riesce a farci credere a profezie palesemente fallite o sconclusionate può riuscire a farci credere qualunque cosa. Infatti così è: basta l’autorità della tradizione a far sì che milioni di persone leggano frasi prive di senso specifico e vi trovino profondi significati, «misteri» e promesse che devono prima o poi compiersi. La credenza nel racconto vince sull’evidenza. La fede, come notava Nietzsche, spesso «significa non voler sapere quel che è vero». Ci si tappa le orecchie di fronte alle smentite della realtà e si preferisce continuare a credere alla storia, costi quel che costi. È un atteggiamento umano comprensibile: accettare che il proprio credo sia fondato sul nulla di fatto sarebbe troppo doloroso, significherebbe ammettere di aver speso anni pregando un’ombra. Meglio trovare una scusa, raddoppiare la puntata della fede e convincersi che, «se la profezia non si è avverata, è colpa nostra che non l’abbiamo capita bene». Come dice un antico adagio: non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire.
Esperienze religiose e altre visioni: quanto valgono?
A questo punto un credente potrebbe obiettare: «Va bene, i testi li hanno scritti degli esseri umani, le storie possono essere inventate… ma io sento Dio nella mia vita. Ci saranno pure milioni di persone che hanno avuto esperienze spirituali, miracoli, visioni! Quella sarà una prova che Dio c’è, no?». Ecco, questo è un altro argomento delicato: il valore delle esperienze personali.
Molti credenti portano a sostegno della propria fede il fatto di aver vissuto momenti intensi, magari inspiegabili, che interpretano come contatto con il divino: una preghiera esaudita, una guarigione inaspettata, l’apparizione di una figura sacra, una voce interiore, un’estasi mistica. Anche qui però dobbiamo fare attenzione: per quanto sincera e potente sia un’esperienza soggettiva, essa resta soggettiva. Non possiamo pretenderla vincolante per gli altri, né usarla come prova oggettiva di una verità sovrannaturale. La mente umana è capace di produrre un intero cinema interiore senza bisogno di input esterni: sogni, allucinazioni, visioni, percezioni distorte… un vero repertorio di fenomeni «straordinari», che però hanno origine nel cervello.
Facciamo qualche confronto. Ci sono persone che giurano di essere state rapite dagli alieni durante la notte: descrivono nei dettagli esseri, astronavi, esperimenti subiti. Altri affermano di aver visto fantasmi di parenti defunti o di essere usciti dal proprio corpo durante un’operazione chirurgica. Altri ancora sostengono di comunicare regolarmente con spiriti o entità di vario genere. Queste esperienze, per chi le vive, possono essere assolutamente reali. Ma cosa dovremmo dedurne noialtri? Dobbiamo forse crederci senza alcuna verifica? Tendenzialmente no. Sappiamo che la mente può giocare brutti scherzi. I rapimenti alieni, ad esempio, si spiegano bene con episodi di paralisi nel sonno uniti a immaginazione fertile: il soggetto si sveglia semi-immobile, sente presenze ostili e, influenzato da racconti di fantascienza, visualizza alieni che lo immobilizzano. Un tempo episodi simili venivano interpretati come attacchi di demoni o streghe notturne: la cosiddetta Pesadilla o Old Hag del folklore. Oggi, in un’epoca di UFO e X-Files, la stessa sensazione viene rielaborata come rapimento extraterrestre. Il contenuto dell’esperienza cambia col cambiare del contesto culturale, mentre la base neurofisiologica (un disturbo del sonno) rimane la stessa. Ecco un primo punto chiave: molte esperienze che paiono confermare una realtà soprannaturale in realtà riflettono ciò che la persona già crede o si aspetta di vedere.
Analogamente un cristiano devoto che entri in uno stato alterato di coscienza (per digiuno, preghiera intensa, stress emotivo eccetera) potrà vedere la Vergine Maria o Gesù, un induista in circostanze simili potrà vedere Krishna o Kali, un sufi islamico potrà avere la visione del Profeta o sentire la voce di Allah, uno sciamano animista vedrà lo spirito di un animale totem. Insomma l’esperienza «mistica» c’è, ma ognuno vede quello in cui già crede, o quanto meno ciò che la propria cultura gli ha impiantato nell’immaginario. Questo suggerisce che l’origine del fenomeno sia interna alla psiche, non esterna. Se ci fosse un unico vero Dio a mostrarsi, perché apparirebbe in forme così diverse e incoerenti? Perché a Fatima la Madonna si mostra a tre pastorelli cattolici, mentre nello stesso periodo una divinità diversa rivela messaggi a qualche santone in India? E perché nessuno dei due appare mai, poniamo, a un astronomo scettico dentro un Osservatorio, in modo da convincere anche un non credente con un bello shock mistico controllato? Il quadro che emerge è il seguente: le esperienze spirituali confermano sempre la fede di chi le vive, mai la cambiano in qualcosa di totalmente nuovo. Un cristiano in estasi non riceverà improvvisamente la rivelazione che il dio Shiva è l’unico vero, ma avrà visioni conformi al cristianesimo. Questo fatto da solo dovrebbe far riflettere: se fosse Dio a parlare o a manifestarsi, non dovrebbe farlo in modo univoco, rompendo gli schemi? Invece sembra proprio che le persone, in momenti particolari, attingano al proprio subconscio e trovino lì le figure già pronte della loro religione.
Ma c’è di più. Molte esperienze religiose non sono altro che inganni dei sensi o interpretazioni emozionali di eventi del tutto normali. Un esempio su tutti: la cosiddetta sensazione della «presenza» durante momenti di stress o di isolamento. Alcune persone, trovandosi sole al buio in preghiera o in meditazione, riferiscono di sentire come una presenza accanto a sé, magari identificata con un angelo, con Dio stesso o con un santo. Ebbene, questa sensazione è relativamente comune anche fuori del contesto religioso: alpinisti sfiniti in scalata l’hanno provata – per loro era la «presenza amica» di un compagno invisibile che li affiancava –, naufraghi alla deriva pure – il famoso esploratore Shackleton parlò di una presenza incorporea durante la traversata dell’Antartide —, perfino persone in semplice stato di isolamento sensoriale. Il cervello umano, quando è sotto pressione o in condizioni particolari, può creare l’illusione vivida di qualcuno vicino a noi. I credenti interpretano questa presenza come la loro figura spirituale preferita (l’angelo custode, la Vergine, Gesù). Altri la vivono magari come il fantasma di una persona cara. Altri ancora come un’entità sconosciuta ma tangibile. La causa potrebbe risiedere nel modo in cui il cervello modula la percezione del sé e dell’ambiente: se quei confini interni si sballano un po’, è come se proiettassimo fuori una parte di noi e la percepissimo come «Altro». Risultato: «Sento qualcuno». È comprensibilissimo che una persona religiosa, vivendo ciò, ne esca ancora più convinta che il suo Dio non la abbandona. Ma dal di fuori, sapendo quanti tranelli può giocare la nostra neurobiologia, non possiamo considerare questa testimonianza come prova di un ente divino oggettivo.
La stessa cautela va applicata ai cosiddetti miracoli o guarigioni. Chi crede dirà: «Ho pregato e sono guarito, quindi è stato Dio!». Ma quante volte ciò accade (coincidenze fortunate, guarigioni spontanee, effetti psicosomatici) e quante volte invece la guarigione non avviene nonostante le preghiere? Sappiamo bene che di fronte a guarigioni mancate il credente non conclude «dunque Dio non esiste», ma piuttosto «Dio ha detto no» o «il miracolo è un altro», magari la forza di sopportare la prova. Insomma l’interpretazione è sempre favorevole al racconto di partenza: se succede qualcosa di bello è l’esaudimento divino, se non succede niente è un disegno imperscrutabile comunque divino. È una logica a tenuta stagna, inconfutabile qualunque cosa accada, e proprio per questo epistemicamente debole. Una teoria che spiega tutto e il contrario di tutto di fatto non spiega niente. È solo un guscio elastico in cui si può infilare qualunque evento post hoc.
Consideriamo poi il valore aneddotico delle esperienze religiose. «Mia zia è guarita dal cancro dopo un pellegrinaggio», «Ho sognato Padre Pio e poi mi è successa una cosa bella», «Ho sentito una voce durante un incidente e mi sono salvato». Benissimo. Per ogni aneddoto di questo tipo, ce ne sono mille di segno opposto: persone pie e devote che non ricevono alcun aiuto visibile nelle difficoltà, visioni di santi che dicono banalità o nulla di verificabile, sogni miracolosi che non portano a nulla se non alla consolazione personale. E soprattutto aneddoti analoghi in ogni religione: il devoto indù guarito dopo aver invocato Vishnu, il buddhista sopravvissuto per intercessione di una reliquia del Buddha, il fedele di una Chiesa evangelica che «parla in lingue» e si sente riempito dallo Spirito Santo. Per il cattolico medio le guarigioni induiste non provano la verità dell’induismo: al massimo saranno opera del demonio o suggestioni. Vceversa per l’indù una guarigione mariana non dimostra affatto che Gesù è l’unico salvatore. E l’ateo, con occhio scettico, può benissimo mettere tutto nel calderone delle capacità di autoguarigione del corpo e della mente, magari coadiuvate dall’effetto placebo della fede. Dopotutto si sa che l’ottimismo e la speranza possono influire sul sistema immunitario: la preghiera in sé forse non agisce sul tumore, ma di certo riduce lo stress del malato, e lo stress a sua volta incide sul decorso. Alla fine se uno guarisce ringrazierà la Madonna, se non guarisce «era volontà di Dio». In entrambi i casi la narrazione è salva.
E le apparizioni clamorose, con decine di testimoni? Ad esempio le visioni mariane come Lourdes, Fatima, Medjugorje. Anche qui, chi c’era giura di aver visto o sentito qualcosa, chi non c’era e non crede resta scettico. A Fatima nel 1917 ci furono migliaia di persone che dissero di aver visto il Sole danzare in cielo (il famoso «miracolo del Sole»), ma nessun Osservatorio astronomico registrò movimenti solari quel giorno. E meno male – aggiungo io –, altrimenti si sarebbe trattato di un’oscillazione cosmica con conseguenze catastrofiche in tutto il globo! Dunque come la mettiamo? I credenti parlano di fenomeno sovrannaturale locale, i non credenti di allucinazione collettiva, complice il fissare il Sole troppo a lungo, che causa effetti ottici strani. Una considerazione interessante: a Fatima molti videro il Sole roteare, ma nessuno vide – poniamo – la Luna ballare o le stelle cadere. Perché? Perché l’aspettativa psicologica era di vedere un segno nel cielo, e il più facile da guardare era il Sole velato dalle nubi. Ecco che tutti fissano il Sole e dopo un po’ le retine e il cervello fanno scherzi: il disco solare pare muoversi, cambiare colore, zigzagare. Un fenomeno noto a chi studia l’oftalmologia. A Lourdes invece la visione era ristretta a una ragazzina, Bernadette, e tutti gli altri vedevano solo lei in trance e hanno scelto di crederle. A Medjugorje le presunte apparizioni iniziali furono viste da sei giovani e curiosamente in alcune fasi non tutti vedevano la stessa cosa: un indizio del fatto che almeno in parte si trattava di autosuggestione individuale. Oggi quel luogo è meta di pellegrinaggi enormi, e c’è gente che afferma di vedere il Sole pulsare o statue che lacrimano o altre meraviglie. Ma – guarda caso – sempre fenomeni che non lasciano tracce concrete, non si fanno filmare in modo inequivocabile, non producono effetti tangibili se non nell’animo di chi già ci crede.
Con questo non intendo dire che tutti i credenti siano pazzi o stupidi. Affatto. Le esperienze personali possono essere intense e sincere, lo riconosco. Ma, proprio perché tengo alla verità, devo anche dire chiaramente che le esperienze soggettive non sono una buona base per l’accertamento oggettivo. Se mille persone mi raccontano mille cose diverse su cos’hanno visto o sentito e ognuna ne trae conferma della propria distinta fede vuol dire che la spiegazione più semplice è che ciascuno si sia autoalimentato la propria convinzione. La «prova interiore» vale solo interiormente, appunto. Per gli altri è un racconto di seconda mano, che si aggiunge a mille altri in contraddizione tra loro. Torniamo sempre lì: al racconto umano. Anche la nonna guarita o la visione del santo non sono di per sé «Dio»: sono eventi interpretati in un certo modo e narrati alla comunità dei fedeli, che li accoglie e li tramanda magari ingigantendoli un po’ a ogni passaggio. Dopodiché diventano anch’essi parte della tradizione, e chi vi nasce dentro li accetterà come fatti acquisiti, magari senza conoscerne i dettagli o le possibili spiegazioni alternative.
C’è poi un ultimo paragone da fare, un po’ crudo ma necessario. Immaginiamo una persona che oggi venisse da noi dichiarando: «Ieri sera ho parlato con Dio, mi è apparso in salotto e mi ha dato questo messaggio per l’umanità». Come reagiremmo? Probabilmente con scetticismo, per non dire che chiameremmo un bravo psichiatra. Se insistesse nel dire di vedere e sentire regolarmente figure divine, la sua salute mentale sarebbe messa in discussione. Ebbene, molti santi del passato (e fondatori di religioni) hanno affermato proprio questo: di parlare con Dio, di vedere angeli, di udire voci celesti. Perché siamo disposti a credere a loro e non crederemmo al nostro ipotetico conoscente contemporaneo? In fondo l’unica differenza è che le visioni dei santi/profeti ce le raccontano i libri venerabili, mentre il conoscente ci riferisce le proprie a voce adesso. Io vedo due possibilità: o ammettiamo che il nostro scetticismo odierno è giusto, e allora per coerenza dovremmo applicarlo anche retroattivamente ai racconti antichi, oppure concediamo che magari qualcuno anche oggi potrebbe davvero parlare con Dio, ma allora perché non diamo retta ai tanti «profeti» moderni che affollano i reparti psichiatrici o che predicano nuove rivelazioni ai margini della società? La verità è che in genere non crediamo alle esperienze mistiche altrui a meno che non siano certificate da un bollino di «tradizione». Se una visione è narrata nella Bibbia si tende a rispettarla, se è narrata sul blog di un tizio qualunque la si irride. Eppure la probabilità che entrambe siano allucinazioni è pressoché identica. È un fatto duro da digerire, ma è così: la differenza la fa solo la forza del racconto collettivo. Una visione isolata muore con la persona o al massimo diventa un caso di studio, una visione che si inserisce in una cornice narrativa già esistente (per esempio «la Madonna continua ad apparire perché la storia sacra prosegue») diventa alimento per la fede. Non per il suo contenuto oggettivo – che resta inconsistente per chiunque altro – ma per il suo valore simbolico e psicologico dentro quella cornice.
Dulcis in fundo: immaginiamo che oggi, proprio ora, io dichiari che Dio mi è appena apparso. Nessun tramite, nessun sogno, nessuna rivelazione mistica: un contatto diretto, inequivocabile. E supponiamo che questo Dio, con tono solenne e definitivo, mi abbia annunciato che ha deciso di autoeliminarsi. Sì, proprio così: Dio ha scelto di scomparire per sempre, senza lasciare traccia della sua esistenza, e che nessuno potrà più avere prove di lui da questo momento in poi. Ecco, se anche io raccontassi questo episodio, con tutta la convinzione e la forza mistica possibili, perché nessuno dovrebbe credermi? Perché la mia affermazione non sarebbe ritenuta alla pari delle rivelazioni di Mosè, di Maometto, dei profeti? In fondo anche loro hanno semplicemente detto: «Dio mi ha parlato, credetemi». La mia unica colpa sarebbe quella di essere arrivato troppo tardi, di non avere una tradizione millenaria alle spalle pronta a trasformare le mie parole in dogma. Ma la struttura è identica: una dichiarazione individuale elevata a Verità assoluta. Eppure nessuno costruirà una religione sulla mia visione, nessuno scriverà un libro sacro sul Dio che si è autoannullato. Questo mostra quanto il contesto e la ripetizione contino più del contenuto: non si crede a Dio in sé, ma alla narrazione che ne è stata fatta, tramandata e confermata dalla comunità. Si crede a ciò che viene narrato come «vero» da chi ha il potere culturale di definirlo tale.
Non di Dio, ma delle storie su Dio
In tutto questo discorso – te ne sarai accorto – ho parlato sempre di ciò che gli esseri umani dicono di Dio. Non mi sono lanciato in affermazioni metafisiche sull’esistenza o l’inesistenza di un Essere Supremo in sé. Non ho «negato Dio» come entità astratta: mi sono limitato a criticare le narrazioni umane su di lui. Ed è proprio questo il punto finale che voglio sottolineare.
Quando ci si impegna in una critica religiosa come quella esposta in questa trilogia, qualcuno potrebbe dire: «Ma allora tu pretendi di capire Dio? Di dire che cosa Dio farebbe o non farebbe?». Niente affatto. Io sto dicendo che non so nulla di Dio, e nemmeno loro (i credenti) sanno nulla di Dio se non quello che hanno letto o udito da altri esseri umani. Non stiamo davvero discutendo di Dio in sé, ma dell’idea di Dio che l’umanità si è costruita. È un bersaglio molto terreno, fatto di carta e di parole, non di fulmini celesti. Posso criticare la Bibbia o il Corano senza dover sfidare alcun Creatore cosmico, perché la Bibbia e il Corano li hanno scritti delle persone, con tutti i limiti, i bias, le emozioni e le intenzioni di cui le persone sono capaci. Posso dubitare delle apparizioni mariane senza dover duellare con la Regina del Cielo, perché sto semplicemente mettendo in dubbio ciò che dei testimoni umani hanno affermato di aver visto. Sto, in altre parole, smascherando il narratore, non il personaggio.
Immaginiamo di leggere un romanzo mediocre e di criticarlo perché la trama non sta in piedi: nessuno ci accuserebbe di «arrogante blasfemia» verso i protagonisti della storia, perché tutti sanno che sono figure inventate dall’autore. Ecco, con la religione sembra funzionare diversamente: appena critichi le incongruenze della «trama» (sacra), i credenti pensano che tu ce l’abbia con il protagonista (Dio). Ma il protagonista in questione, finché resta un’entità invisibile e indimostrabile, esiste solo nel racconto. Io critico quel racconto, evidenziandone le falle, le contraddizioni, le evidenti impronte digitali umane. Che poi un Dio vero esista o no è un’altra questione: importantissima filosoficamente, certo, ma al di fuori della portata dell’analisi empirica. Il Dio vero, se c’è, non lo abbiamo a disposizione sul tavolo degli esperimenti. In compenso abbiamo pile e pile di narrazioni che pretendono di descriverlo: quelle sì che possiamo analizzarle, confrontarle, valutarle con senso critico.
E che cosa scopriamo, quando facciamo quest’analisi? Che le narrazioni su Dio portano tutti i segni dell’origine terrena. Raccontano i pregiudizi dell’epoca in cui sono nate: ad esempio certi passi biblici grondano sessismo e tribalismo, riflesso della cultura di pastori di 3000 anni fa. Rispecchiano l’ignoranza scientifica del tempo: vedi alla voce «Terra piatta sotto una cupola di cielo», cosmologia presente nei testi sacri più antichi. Includono errori, false partenze, aggiustamenti in corsa: abbiamo parlato delle profezie mancate e di come si è cercato di rimediare. Presentano divergenze dottrinali enormemente diverse una dall’altra, come è ovvio se consideriamo che differenti popolazioni se le sono inventate indipendentemente. E soprattutto queste narrazioni cambiano ed evolvono nel tempo: ogni religione attuale è diversa da com’era alle origini. Il cristianesimo odierno non pratica più certi rituali ebraici presenti invece nel Vecchio Testamento, l’Islam ha sviluppato teologie sofisticate assenti nel Corano originario, l’induismo odierno è molto diverso dal culto vedico di 3000 anni fa. Non parliamo poi delle innumerevoli divisioni interne: centinaia di Chiese e di sette in conflitto interpretativo tra loro anche all’interno della stessa fede di base. Tutto ciò segnala relatività culturale, non Verità assoluta. Se davvero esistesse una sola Verità rivelata da un solo Dio, perché mai sarebbe così difficile mettersi d’accordo perfino tra credenti dello stesso Dio? È evidente che ci troviamo di fronte a prodotti umani, con tutte le loro varianti e i loro adattamenti.
Alla fine della fiera, la mia non è (solo) una posizione polemica: è quasi una constatazione ovvia, una volta aperti gli occhi. I credenti non credono in Dio: credono agli esseri umani. Credono a libri scritti da umani, a prediche fatte da umani, a miracoli raccontati da umani, a dottrine interpretate da umani. L’essere umano al centro, non Dio. Forse dovremmo essere tutti un po’ più onesti intellettualmente e ammettere questa realtà semplice. Il che potrebbe avere anche un risvolto positivo: se capissimo che in realtà è sempre stato l’essere umano a parlare a sé stesso attraverso il mito di Dio, forse smetteremmo di delegare a un Aldilà immaginario le nostre migliori energie. Credere nell’essere umano invece che in un Dio non significa fare dell’umanità un idolo, ma riconoscere che sta a noi inventare e scegliere il significato della nostra vita. Finora lo abbiamo proiettato in cielo per millenni, confidando in padri onnipotenti immaginari. Ora è tempo di riprendercelo.
Mi rendo conto che per un credente tutto ciò è difficile da accettare. È più rassicurante pensare che dietro le quinte ci sia davvero un Regista divino, e non solo un esercito di sceneggiatori umani. Ma guardiamo in faccia la situazione: abbiamo solo il copione scritto dagli sceneggiatori. Il Regista non si è mai visto in scena. Forse, semplicemente, il Regista è una creazione della sceneggiatura stessa. Un personaggio di cui gli attori si autoconvincono per dare un senso allo spettacolo. Una cosciente illusione collettiva. Come nei bambini che giocano a guardia e ladri e «ci credono per finta» finché dura il gioco, l’umanità ha giocato a servi e dèi, a peccatori e redentori, narrando storie sempre più elaborate. Storie a volte bellissime, poetiche, consolatorie – riconosco che possono esserlo – ma pur sempre solo storie.
Con questo non voglio togliere la poesia o il fascino alle narrazioni religiose. Posso anche leggerle e apprezzarle come miti, come ha fatto ad esempio Joseph Campbell studiando «l’eroe dai mille volti» che accomuna tante tradizioni. Posso trovare saggezza in certe parabole, elevazione in certi inni. Ma ciò è ben diverso dal crederli letteralmente veri. Posso godermi la Divina Commedia di Dante ed emozionarmi, ma non è che io creda davvero che lui abbia fatto un tour guidato all’Inferno, in Purgatorio e in Paradiso. Ecco, con la Bibbia e gli altri Libri sacri bisognerebbe fare lo stesso: riconoscerne (eventuali) spunti morali o letterari ma smettere di trattarle come guide telefoniche del Cielo. Perché così facendo alimentiamo un sistema di pensiero pericolosamente irrazionale: quello che mette le storie al di sopra della realtà verificabile, fino a negare l’evidenza pur di salvare la leggenda.
Alla fine non stiamo discutendo di cosa vuole Dio, di cosa fa Dio, di perché Dio permette il male o simili. No. Di quello non sappiamo nulla. Sarebbe come dibattere sui gusti estetici degli unicorni. Stiamo discutendo di cosa raccontano gli esseri umani a proposito di «Dio». È un dibattito tutto interno all’umanità, un processo alle fonti umane della fede. Dio, eventualmente, ne è solo il convitato di pietra. E personalmente, dopo aver passato in rassegna testi sacri, profezie, dogmi, miracoli e quant’altro, vedo ovunque la mano dell’essere umano e nessuna traccia certa di altro. Vedo la fantasia, la paura, la speranza, l’ignoranza, l’astuzia, la follia, la genialità umana, ma il divino, se c’è, è sepolto talmente in profondità sotto strati di racconti che non se ne può estrarre niente di affidabile.
Concludo dunque con un invito alla consapevolezza: quella di distinguere tra Dio e l’idea di Dio. Tra la realtà – qualunque essa sia – e la narrazione. Possiamo continuare a discutere per secoli se Dio esiste o no, ma rischia di essere un falso problema finché non chiariremo cosa intendiamo con quella parola e da dove prendiamo le informazioni al riguardo. Per come la vedo io, Dio è un personaggio letterario di enorme successo, creato a più mani dagli esseri umani attraverso i tempi. Come tutti i personaggi, può ispirare, affascinare, spaventare. Ma resta un personaggio, non l’autore. L’autore – ahinoi o per fortuna – siamo noi. Lo siamo sempre stati.
In fondo non si è mai creduto in Dio ma sempre e solo nelle parole umane. E forse è arrivato il momento di assumercene la responsabilità. Smettere di cercare la verità in antichi racconti e cominciare a cercarla nella realtà, nel dialogo onesto fra esseri umani, nelle prove concrete e nel ragionamento critico. Lì almeno sappiamo di muoverci su un terreno solido, senza la pretesa di verità assolute calate dal cielo ma anche senza l’inganno di venerare come assoluto ciò che non è che un’eco di voce umana levatasi nel buio dei millenni.
Non Dio, ma l’essere umano. È sempre stato l’essere umano il protagonista nascosto dietro il sipario del sacro. Riconosciamolo e forse scopriremo che, tolta la maschera divina, possiamo finalmente guardare in volto noi stessi. Con tutti i nostri limiti, ma anche con la libertà di chi non dipende più da favole per dare un senso al mondo. In ultima analisi, liberarsi delle narrazioni non significa rimanere senza significato: significa poter scrivere da capo la propria storia, assumendosene la piena responsabilità. E chissà che questa non sia la più grande forma di rispetto verso quell’idea di divino che tanto abbiamo venerato: comprendere che, se esiste, non può manifestarsi che attraverso di noi, oppure – come io credo – che siamo stati noi a manifestarlo, a inventarlo, a narrarlo dall’inizio. In ogni caso il potere creativo della narrazione è sempre appartenuto agli esseri umani.
E allora che gli esseri umani finalmente se ne riapproprino, smettendo di attribuirlo a entità invisibili. Qui finiscono i racconti e inizia la realtà.
Dario
Avvertenza:
La lingua di questo articolo cerca di conciliare l’inclusività con la leggibilità e la scorrevolezza. Nessuno si offenda quindi se evita le ripetizioni e usa il plurale sovraesteso. Ché mi spiace, ma la schwa anche no.
Qui sotto trovi la possibilità di commentare quest’articolo. Per farlo, devi
1. confermare che sei ateo/a,
2. essere consapevole che, se menti, stai commettendo il gravissimo peccato di apostasia,
3. aspettare che il commento sia approvato dall’admin.
L’approvazione dei commenti dipende dall’insindacabile e inappellabile giudizio dell’admin. Se vuoi saperne di più a proposito dei commenti, puoi consultare le FAQ.
Inoltre puoi commentare gli articoli e i post nel Gruppo Facebook de L’Eterno Assente, se ti iscrivi al Gruppo dopo aver risposto a una semplice domanda.
Potrebbero interessarti anche gli articoli di questi Percorsi:
Potrebbero interessarti anche i video di questi Percorsi:
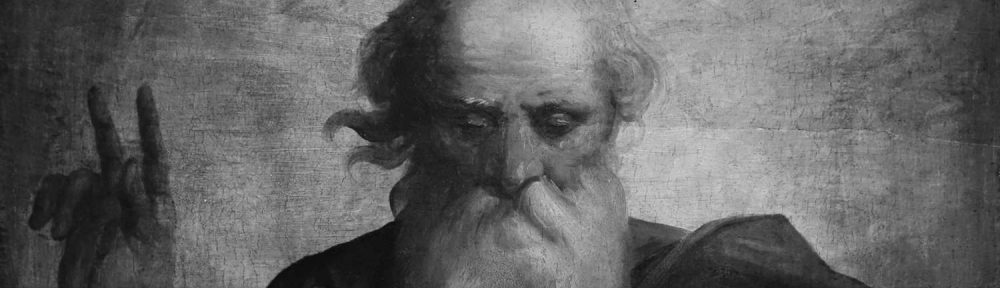
Grazie per il bell’articolo. Nel mio caso la crepa da cui è partito il crollo è stata proprio quella che hai menzionato all’inizio. Realizzare che le assurdità delle altre religioni erano simili alle nostre.
Articolo molto lungo ma eccellente spiegone. Un pò triste perchè l’assenza di un DIO mi causa un terribile senso di vuoto e di paura dell’aldilà (sostalziamente il niente assoluto), ma la mia razionalità mi impone di concordare pienamente con quanto scritto da Dario. Sono Ateo per forza, non per volontà.
Ciao Plasmatek,
grazie per la lettura.
Guarda io non mi preoccuperei tanto della morte: quando ci siamo noi non c’è lei e quando c’è lei non ci siamo noi, diceva un saggio.
Quando si spegnerà l’interruttore non avrai più nulla a cui pensare perchè non penserai più e quindi la paura non esisterà come il dolore nè la gioia eccetera.
Grazie Dario per questo piccolo saggio ben scritto che rappresenta perfettamente le mie idee che attraversano un grande arco di tempo. Questi pensieri li avevo sia da ragazzo credente al minimo necessario, qualche dubbio nel periodo fervente e conferme in questi ultimi anni da ateo.
Leggendo questo io tutte le volte mi faccio la stessa domanda. Possibile che menti intelligenti non si facciano una domanda? Dopo un po’ mi do la risposta da solo. Meglio una dolce bugia che una amara verità. Ma la domanda comunque mi stupisce ancora. Il pensiero che ci godiamo degli uomini e non di dio l’ho avuto appunto già da ragazzo. Pensavo… ma io mi sto fidando dei miei, che è gente buona, così come i nostri amici e così via. E così dovrei arrivare a dio, giusto? Ma se nel mezzo fosse successo qualcosa? Qualcuno avesse imbrogliato? O si fosse sbagliato? Ma da ragazzo, visto anche il carattere facevo spallucce e dicevo “vabbè poi si vedrà”
Non mi dilungo, quando ho cominciato a pormi veramente delle domande sono giunto a ciò che hai scritto.
Moltissime di queste frasi le utilizzerò, cosa che peraltro già faccio, nei vari commenti sui social. Anche se per molti che hanno occhi ed orecchie foderate non troveranno spazio, anzi ingresso.
Grazie 👍
Ciao Rainbow,
grazie per il tuo commento e la tua tua attenta lettura.
Io penso che prima di prendere una posizione forte che può incidere sulla tua vita anche a livello pratico e non solo etico o spirituale, bisogna farsi delle domande. Io non sono convinto che la maggior parte dei credenti si sia chiesta ” in cosa credo?”.
Da irrilevantista quale sono, io mi sono fatto tutte le domande includendo ” ma io sono ateo di un dio? cioè ho una relazione con dio anche se nullificatrice?” “ha senso parlare di dio in qualsiasi modo?” eccetera,,,
Spesso l’ovvio non lo controlla nessuno a prescindere dalla bontà della fonte o dell’intento.
Un abbraccio,
Dario
“Si crede a Mosè, a Paolo di Tarso, a Maometto, a Joseph Smith, al guru di turno o al teologo interprete.” Ahah, quanta ingenutà! Nessun credente è stato convinto da una riga di questi racconti. Tutti sono credenti perché glielo ha detto la MAMMA. E no, mia madre non era credente perché persuasa da un qualche testo: ma perché persuasa da mia nonna e così via fino al più profondo analfabetismo delle donne venete del passato. E neanche la prima si convise per aver letto il Vangelo: sicuramente si fece battezzare per non venire bruciata sul rogo. I credenti di oggi – almeno i Cattolici – sono tutti figli di un’antica paura delle fiamme, che le madri trasmettono ai figli. Io non mi sono fatto sbattezzare, perché se premorissi a mia madre lei vorrebbe per me un funerale cattolico. Morta lei, lo farò e mio marito mi darà esequie laiche perché a quel punto il mio cadavere apparterrebbe a lui.
Ciao Enrico,
grazie per il tuo commento.
Devo puntualizzare due questioni, se mi consenti.
1) Ci sono migliaia di persone che seguono molto da vicino i precetti dei libri sacri (pensa solo all’Islam ortodosso o ai cristiani evangelisti in America e Sud America o i rabbini che si sbattono sul Talmud) oggigiorno, per non parlare del passato dove i chierici cristiani (ad esempio) letteralmente possedevano la conoscenza religiosa tramite Bibbia/Vangeli essendo gli unici i grado di tramitarne gli insegnamenti durante la messa, si evince benissimo dalle trascrizioni del processo fatto a Giovanna d’Arco, per citarti una fonte. Quindi non sono del tutto d’accordo con te.
2) A me non importa nulla che sia la famiglia, il libro o una visione. Il punto è che nessuno ha contatti diretti con dio in maniera inequvocabile ed anche il mistico/la mistica che dicono di aver avuto queste esperienze o chi fa sogni e poi guarisce eccetera si trasformano in narratori di fatti non riscontrabili perciò, io ho solo preso l’origine degli eventi che risale appunto alle Sacre Scritture. Poi che ci sia anche una matrice socio-culturale va benissimo, mi trovi d’accordo in questo caso, ma non era il centro del mio discorso.
Un caro saluto,
Dario
1) Direi che la totalità di chi segue alla lettera quello che ha letto in qualche libro non lo fa perché persuaso dal libro stesso: ma a causa dell’educazione ricevuta. Non penso esista qualche cristiano evangelico che non mangi maiale o gamberi perché così ha letto nell’Antico Testamento. L’Antico Testamento va bene solo per l’omofobia; non per sottrarci delle ghiottonerie. Poi ovvio che se tu conosci delle comunità nudiste cristiane che rifiutano i vestiti perché “I gigli non filano e non tessono, ma neanche Salomone al culmine della sua gloria si vestì come uno di loro”; allora ok. Nessuno è davvero interessato al Libro: siamo tutti interessati solo a chi questo libro ce lo ha letto e solo alle parti che interessavano a lei. 2) Ho ben capito che non era il centro del tuo discorso. Io ho solo detto che hai sbagliato bersaglio. Tu fingi che l’autorevolezza sia un Libro, quando l’autorevolezza è la Mamma. Non è che qualche volta è un libro, qualche volta la famiglia, qualche altra una visione mistica. E’ sempre e solo la mamma. Quanti Messicani diventano Musulmani dopo aver letto il Corano? E quanti Marocchini diventano Cristiani dopo aver letto il Vangelo? Approssimativamente zero, no? I libri non contano: contano le sculacciate se non vai a catechismo. E le prime convertite erano analfabete, quindi neanche loro sono partite dal libro.
Ciao Enrico,
ti rispondo: a me risulta che i libri siano stati le basi dell’educazione e della tradizione e posso assicurarti che ebrei e musulmani ortodossi non mangiano maiale o mulluschi perchè lo dice il “libro” ci sono una marea di cristiani che osservano a pasqua il rito di non mangiare carne. Pensa solo ai testimoni di Geova altro che mamma e papà quelli hanno un codice super stretto. Voglio dire: che la famiglia ti condizioni va bene ma in origine si parte dalle sacre scritture anche perchè ci sono stati orfani che senza mamma e papà hanno fatto scelte in base alle loro conoscenze spirituali. Chiudo dicendo che chi non si converte leggendo un libro lo fa per 2 motivazioni: 1 ha già un altro libro da seguire 2 ha capito che il libro in questione è una fantasia come gli altri libri.
Complimenti. Dario!
Hai scritto un eccellente trattato che demolisce le fede in dio, in qualsiasi dio. Hai scritto bene usando un eccellente italiano, con una rara precisione terminologica e una razionalità ineccepibile.
Però mi permetti qualche domanda?
Per chi hai scritto? Per te stesso per chiarirti le idee e confermare il tuo ateismo? Oppure hai scritto per chi è già ateo convinto?
Non credo che chi segue l’Eterno Assente non sappia già quello che hai esposto e non ne sia convinto. Per quanto mi riguarda, ho letto tutto e, seppure non vi ho trovato nulla di nuovo, ammetto che tutto è esposto con chiarezza e mi ha dato una eccellente sintesi delle ragioni dell’ateismo Dunque la lettura mi è stata utile come un ripasso e una verifica.
Ma pensi che i credenti leggano il tuo saggio e meditino sulle tue osservazioni? La mia esperienza di dialogo con i credenti è piuttosto deludente; è, come ha scritto Choam, quella dello scacchista che ha giocato contro un piccione il quale ha ignorato le mosse, ha rovesciato i pezzi, ha defecato sulla scacchiera, e se ne è andato via sicuro del suo successo.
Tuttavia non ho la pretesa di “capire tutto e di capire solo io”. Quindi, da alcuni anni, conosco un testimone di Geova con il quale discuto anche di religione; e da un anno conosco un sacerdote cattolico molto bergogliano, e quindi un po’ critico del cattolicesimo tradizionale. Con entrambi c’è un discreto rapporto di amicizia e, a parte la fede, anche un buon rispetto reciproco. Invierò a loro il tuo saggio con l’invito di leggerlo tutto e dirmi che cosa ne pensano. Se ci sarà una risposta te la farò conoscere tramite Choam.
Se ci sarà una risposta potrai comunque postarla qui fra i commenti. Non è necessario passare attraverso di me.
(Comunque i commenti io li leggo tutti prima di approvarli, sicché sì, alla fine passa tutto attraverso di me.)
Ciao Agostino,
grazie per i tuoi complimenti, per aver letto il mio scritto e per le tue domande a cui provo a rispondere.
1) Per chi ho scritto : io sono partito asserendo che è inutile dibattere su dio sopratutto con i credenti quanto è inutile per i credenti (spcificatamente quelli de dio abramitico) credere in un essere che è per ammissione delle loro stesse fonti di credo, imperscrutabile e ne ho esposto le ragioni. Diciamo che era un messaggio più per gli atei che per i credenti dire 70% – 30%.
Poi però mi sono detto ma stiamo veramente, in ogni caso, discutendo di dio? O di qualcos’altro? Allora ho scritto “la breve storia di Dio” dimostrando la sua evoluzione, anzi regressione, da un tutto panteistico e materiale ad un nulla adimensionale, imponderabile, impalpabile eccetera.
Infine ho chiuso con l’articolo di cui sopra, che è un messaggio questa volta per i credenti più che per gli atei, direi un 80% 20% di “Paretiana” sintesi.
Intendo dire che un ateo a mio avviso, se proprio vuole discutere con un credente dovrebbe avere questi tre pilastri con le tre domande fondamentali da fare al suo interlocutore :
dio è imperscrutabile?
Conosci la storia di dio?
Sei sicuro di credere in dio?
E il credente dal canto suo dovrebbe avere ben chiaro che, queste domande e possibilmente le risposte, non possono essere esluse perchè descrivono la realtà dei fatti in maniera inequivocabile.
Chiudo dicendo che non ho nessuna pretesta di “successo” tra i credenti ma se qualcuno avrà coraggio e voglia di rispondere, mi trova qui. Chiaramente avrei dovuto cambiare registro linguistico per creare un saggio e non un articolo ma essendo cristiani mi perdoneranno.
Un caro saluto,
Dario
Caro Dario, innanzitutto complimenti per la fluidità e la stesura di un pensiero che si legge tutto di un fiato e senza stancare.Lodevole poi l’assenza di assolutismi.
Ti racconto una storia ,la mia.
Desidero condividerla con te, per richiamare a un ragionamento un pezzo della tua .
Nasco nel ’77 a Milano da una mamma atea, fortemente antifascista per lo schifo vissuto da piccola e anche anticattolica per le sevizie psicologiche ricevute dalle suore ,suore che metteranno di conseguenza un odio totale nel cuore di mia mamma per la chiesa cattolica ,che identificherà per quello che è : una perversa impostura!
Mio papà non ha nemmeno i sacramenti, ritenuti inutili dai miei nonni già svegli da questi dogmi nei primi ‘900 e cresce libero dai condizionamenti religiosi, non dico che sia ateo, ma non è minimamente interessato.Scrivo questo per sottolineare che entrambi non avevano mai avuto nessun retaggio religioso.
Tutto questo fino al ’77 in cui nasco io , e per una fatalità all’ospedale Mangiagalli l’infermiera senza chiedere permesso a mia mamma se volessi il suo latte materno o meno mi mette in bocca un biberon dal quale non essendo probabilmente sterilizzato a dovere, contraggo un batterio che mi porta l’enterocolite acuta necrotizzante ,sottolineo che nel ’77 la neonatologia e la terapia intensiva neonatale erano ancora in fase di sviluppo e che quindi la sopravvivenza dei neonati con gravi problemi intestinali era bassissima rispetto agli standard attuali.
Le notizie dei medici non sono per niente confortanti, sono ridotto a una larva e sono destinato a morte certa ed entro poche settimane visto che non sono in grado di nutrirmi nemmeno col latte materno.
Tutto questo porta mia mamma al baratro della disperazione e depressione, mi racconterà che i pensieri di suicidio sono l’unica via di fuga per lei ,sembra infatti che al peggio non vi sia fine , finchè da li a poco vista la gravità della situazione passa mia zia a casa per un conforto e invita mia mamma in una piccola chiesa evangelica.
Mia mamma è restia, per via del suo passato ma non avendo più nulla da perdere accetta l’invito.
La faccio breve, dopo una preghiera collettiva tipica delle chiese evangeliche fatta dal pastore e dopo aver chiesto a mia mamma un atto di fede in Gesu, io guarisco all’istante e nel giro di un mese scarso riprendo tutto il peso e la vitalità di un neonato completamente sano.
I medici muti ,mia madre muta ,mio padre muto e io pure perchè non avevo mai smesso di piangere avendo avuto l’intestino perforato e un ombelico oramai fuoriuscito.
Tutto bene quello che finisce bene?Beh insomma ….lo scisma si era creato, cosa è successo realmente?Perchè qualcosa è successo, e mia mamma lo aveva vissuto quel momento speciale ,quella sensazione di presenza che hai accennato prima, in questo caso di benevola presenza e mia mamma aveva avuto dentro di se la piena certezza della mia guarigione.Anche mio papà riconoscerà incredulo che quel creatore si è manifestato.
Adesso se c’è una figura che manca quanto all’ateo tanto al religioso ,quello sono io ” l’incastrato”
Dove mi colloco?Perchè tutto quello che tu hai scritto è esattamente che penso anch’io ma nello stesso tempo sò che è avvenuto qualcosa di inspiegabile e non una volta sola (non mi allungo per non andare fuori tema)
Certo, come uno che vince 50 milioni prendi i soldi e te ne vai, non ti fai il pensiero di perchè io e un altro no?
Sono grato eh? Sia ben chiaro…
Ma questa gratitudine, col tempo, si è fatta più complessa. Non è più solo commozione, è anche domanda.
Perché io sì, e altri no? Perché una madre disperata trova una porta aperta e un’altra invece no? Perché alcuni miracoli accadono, e altri sembrano non arrivare mai?
Ed è qui che nasce il mio spaesamento, il mio essere “incastrato”. Perché non riesco a sposare né il cinismo dell’ateo assoluto, né l’abbandono fideistico del credente che non dubita mai.
Sono in mezzo, sospeso tra due rive: una che mi dice “non è possibile”, l’altra che mi sussurra “è successo”.
E allora vivo così: in equilibrio precario tra ragione e mistero, tra il bisogno di comprendere e l’umiltà di riconoscere che non tutto si può spiegare.
Non chiedo certezze, non voglio etichette. Mi basta che esistano spazi come quello che hai aperto tu con le tue parole: onesti, umani, liberi da assolutismi.
Perché se c’è una cosa che ho capito, è che la verità non sta mai tutta da una parte sola.
Un abbraccio,
MrRobot
Caro MrRobot, grazie ancora per la tua risposta così intensa e per la scelta di portare la tua esperienza in uno spazio di confronto. La tua storia merita ascolto, e io l’ho letta con attenzione e rispetto.
Permettimi però di sottolineare un punto centrale, che resta il cuore della mia riflessione. Anche dando per buono ogni dettaglio del tuo racconto – cioè assumendo che sia andata esattamente così, con una preghiera e una guarigione improvvisa – io lettore esterno sono comunque costretto a crederti sulla parola. Devo fidarmi del fatto che tua madre abbia sentito quella “presenza”, che ci sia stata effettivamente una preghiera, che il miglioramento non abbia spiegazione naturale, che sia avvenuto proprio in quel momento, eccetera. E qui torniamo al punto di partenza: credere a ciò che raccontano altri esseri umani. È esattamente questo il nucleo della mia tesi: nessuno crede “in Dio” direttamente, ma nel racconto che qualcuno fa di Dio.
E se vale per la tua esperienza – sincera, personale, significativa – allora dovrebbe valere anche per la mia. Mettiamo, ad esempio, che io dichiari qui pubblicamente: “Ieri sera mi è apparso Dio in salotto e mi ha detto che ha deciso di auto-eliminarsi. Entro dieci minuti non esisterà più.” Fine del divino. Il messaggio è finito con me, e ora l’ho raccontato a voi. Ecco: ti sentiresti in dovere di crederci? E se no, perché no? Se la mia esperienza non ti basta come prova della verità assoluta, perché dovrebbe bastare la tua a me, o quella di tua madre, o di qualunque altro fedele di qualunque altro culto?
Questo è il punto che continuo a sottolineare: non è un attacco all’intensità delle esperienze personali, ma un invito a riconoscere che, in assenza di criteri oggettivi e verificabili, tutte le esperienze diventano equivalenti. O crediamo a tutto – anche al mio Dio che si è appena “suicidato” – oppure manteniamo un sano sospetto verso ogni racconto, per quanto toccante, se non può essere verificato da altri.
Dobbiamo accettare anche il fatto che l’esperienza non è di per sé un criterio valido per stabilire una verità universale. Resta tua. Resta dentro. Può commuoverti, può cambiarti, può renderti migliore – e questo ha valore – ma non può pretendere di farsi credere senza passare dallo stesso vaglio critico che applichiamo a tutte le altre storie.
Ecco perché continuo a parlare di narrazione, e non di Dio. Perché ciò che ci resta, al netto delle emozioni, sono racconti umani. E solo quelli possiamo davvero analizzare.
Un abbraccio sincero anche a te.
Caro Dario,
apprezzo profondamente la tua risposta, la lucidità con cui poni il problema e il rispetto con cui hai trattato la mia storia. E proprio per rispetto voglio restituirti un pensiero altrettanto onesto.
L’esempio che proponi – Dio che si manifesta nel tuo salotto e ti annuncia il suo auto-annientamento ,mi è chiaro nel suo intento provocatorio, ma credo che manchi un elemento fondamentale che distingue la mia esperienza dalla tua ipotesi: l’effetto concreto.
Nel mio caso, non c’è solo una testimonianza: c’è un prima e un dopo misurabile. C’è un neonato dato per spacciato dai medici, che nel giro di pochi giorni cambia traiettoria. Non chiedo a nessuno di credermi per fede, ma è un dato che almeno per chi l’ha vissuto ha un riscontro reale, tangibile, visibile. Non è solo “mia madre ha sentito una presenza”: è “dopo quella preghiera, un fatto che sembrava impossibile si è verificato”.Mio padre ,mia zia e mio fratello rimangono comunque testimoni oculari di un fatto inspiegabile.
Tu potresti giustamente obiettare: “ma non è comunque verificabile da me, oggi, qui”. E ti do ragione. Ma c’è una sostanziale differenza tra un’esperienza soggettiva senza effetti esterni, e una soggettiva che coincide con un evento oggettivo straordinario. Non fanno la stessa cosa. Non pesano uguale, anche se nessuna delle due può diventare prova universale.
Quello che dici è importante: l’esperienza personale non può fondare da sola una verità condivisa. Ma va anche detto che non tutte le esperienze hanno lo stesso grado di aderenza alla realtà. E quella differenza, anche se non basta a “dimostrare Dio”, merita di essere considerata nel discorso.
Non chiedo che la mia storia diventi dogma. Ma forse nemmeno va archiviata solo come narrazione. Forse esiste un punto intermedio — dove l’esperienza non spiega tutto, ma neppure si ignora.
Il tuo punto di vista l’ho compreso benissimo,ecco perchè non mi stresso più di tanto coi ragionamenti, perchè arrivato a un tot avviene un corto circuito dove per ragione dobbiamo scegliere, ma scegliere cosa se siamo limitati e limitanti?
Sono costretto a mollare qui il ragionamento,( ma ritorno 🙂 devo mettere il piccolo a letto ,scusami
un forte abbraccio!
MrRobot
Ciao, da ex credente, che non ha mai visto un prodigio (sposo in toto ciò che ha detto Dario, come te del resto) ad ateo totale, sento di affermare che le cose strane hanno tutte una spiegazione scientifica non sempre dimostrabile. Perché a te? Per la mia personale opinione frutto del caso. Oddio, io non uso “caso” a caso, ma per “caso” intendo qualcosa che è avvenuto che probabilmente doveva andare così affinché io ne prendessi insegnamento.
Il tuo caso (perdonami 🙏) lo ritengo un evento che ogni tanto capita, che non dimostra assolutamente l’esistenza di una entità che interviene. Dovesse succedere a me, farei spallucce, è una questione fisica, chimica, ecc a seconda dei casi. Come potrei valutare un eventuale divino? Qualcosa che dovrà ancora succedere di cui e impossibile avere qualsiasi informazione.
Sono solo curioso di sapere se questa situazione ti crea disagio, mina la tua serenità.
Ciao
Caro MrRobot, ti ringrazio per la tua risposta sincera, che rispetto e capisco. Il punto però resta intatto: anche dando pieno credito alla tua esperienza, sono comunque io che devo scegliere di crederti, sulla base di un racconto. Questo non rende la tua testimonianza meno autentica, ma conferma che la fede – come ho cercato di mostrare – si fonda sempre su ciò che altri raccontano, non su un contatto diretto.
Riguardo alla differenza tra la tua guarigione e il mio paradosso del “Dio-suicida”: capisco che la tua storia abbia avuto un effetto tangibile, ma anche molte altre narrazioni – che oggi consideriamo folli – hanno avuto effetti concreti. Pensa ai membri delle sette come Heaven’s Gate o Jonestown, che si sono uccisi davvero, convinti da una storia altrettanto “sentita” come vera. La concretezza dell’effetto non garantisce la verità dell’origine.
Non è quindi questione di quantità o intensità dell’effetto, ma della struttura logica: se accetto un evento come segno divino, allora per coerenza dovrei accettare tutti i racconti con effetti straordinari – anche quelli delle religioni altrui, dei visionari, delle sette. E non credo sia questo che vogliamo fare.
Un abbraccio anche a te, e grazie davvero per il confronto aperto.
P.s. Ho dovuto rispondere sotto Rainbow perchè il pulsante risposta per MrRobot non appariva comunque grazie a Rainbow per la sua testimonianza.
Ciao una cosa simpatica, ho scritto per mezz’ora per rispondere al tuo commento. Ho cliccato invia commento, ma sono salito sul treno e la pagina si è bloccata. Ho dovuto fare refresh ed ho perso tutto. Vorrà dire che mi metterò al PC per elaborare meglio una mia risposta.
Pazienza 😊
Ciao MrRobot, oggi noto che il mio messaggio di ieri sera, delle 21.40 oggi è ricomparso! Misteri dell’internet. Meglio così.
Ciao!
Torno qui dopo qualche giorno, per leggere con calma. Ovviamente concordo con Dario, e voglio dare una mia personale opinione sull’esperienza di MrRobot.
Spero di spiegarmi.
Ciò che credo lasci Robot in una via di mezzo sia proprio l’intensità del vissuto. Cinquant’anni con la narrazione di questa esperienza. E’ per forza entrata nel dna, fa parte di lui ormai da sempre e la razione non basta e rifiutarla totalmente. E’ come se dovesse rinunciare ad una parte di sé, il che non è possibile.
Vorrei compararla alla mia esperienza. Anni e anni di storie, sin dalla prima infanzia, ma a differenza di Robot non ho subito un evento particolarmente forte. Ma allo stesso tempo anche per me l’esperienza è stata molto profonda. Nel mio caso ho sentito parlare di focolarini appunto da quando ne ho memoria. Li ho sempre considerati “parenti”. Persone belle che hanno sempre trasmesso amore, fiducia, fratellanza. Ma ad un certo punto la ragione ha cominciato ad avanzare e l’osservazione razionale del quotidiano, come la chiamo io, ha fatto il resto. D’altronde, come già detto, e non so perché, già da adolescente riflettevo sul fatto che gli altri “ci raccontavano storie”. Ma io alla fine, cosa ho visto? Che esperienze ho fatto? Poiché di paranormale non ho mai visto nulla alla fine ci ho dato un taglio.
Unendo i vari pezzi del puzzle tutto sta quadrando.
Se non erro Choam ci chiede: “quale sarebbe un mezzo, un qualcosa affinché ti possa portare a credere in un dio?”
Per me nulla.
Grazie
Definitivo. Grazie Dario e grazie Choam per averlo “ospitato”
Grazie a te per avermi letto,
Un caro saluto.
Dario
Interessante (anche se ti confesso che non ho letto tutto, purtroppo oggi lavoro, ma mi ripropongo di tornarci). Solo, c’è un punto da considerare: alcuni dicono di avere esperienze dirette della divinità. Ci sono persone che dicono di essere state in Paradiso e di aver parlato con Dio. Ovviamente, presumo che molte di queste siano ciarlatani o persone con problemi psichiatrici, ma non posso bollarle tutte come “false e basta”.
Certo, io non credo a nulla di tutto ciò senza prove, come dici giustamente anche tu, ma quel “chi crede in Dio non crede in Dio, crede in persone che gli hanno parlato di Dio”, per quanto vero in generale, presenta delle eccezioni. Questo giusto per spaccare il capello in quattro dal punto di vista prettamente della logica formale.
ciao Nicola,
grazie per il tuo commento.
so che è impegnativo leggere il mio testo è un po’ pesante e lungo…tuttavia c’è la risposta al tuo quesito in almeno due punti che ti riassumo: 1) anche le persone che dicono di aver vissuto esperienze trascendentali, per me non differiscono da quelle che lo hanno scritto su un libro, sono sempre persone che dicono che…2) e come la mettiamo se io stesso ti dicessi che ho visto dio e mi ha riferito che si sarebbe suicidato entro 10 minuti terrestri? Vale o non vale?
Un caro saluto,
Dario
Considerazioni talmente ovvie che, a mio parere, dovrebbero essere la base di partenza per chiunque voglia lasciare la porta aperta all’ esistenza di un potere superiore.
Perciò mi spingo oltre: e se, effettivamente, fossero davvero considerazioni condivise anche tra i credenti? Con l’ unica differenza che, rispetto all’ ateo/agnostico, una volta privato del pensiero magico troverebbe la vita di una monotonia sconcertante.
Senza prenderci in giro, qual è l’ identikit di un fervente religioso? È una persona che non vuole neanche imparare, pigra di cervello, attaccatissima alla sua favola peggio della cozza con lo scoglio.
Ma crede davvero nelle testimonianze di chi dio lo ha conosciuto?
No. La disperazione per la perdita di un proprio caro sussiste, la paura della propria malattia, la priorità garantita alla scienza nei confronti della preghiera quando la situazione si fa seria (e anche prima, per un mal di testa non si prega, si prende un analgesico). Tutto ciò tranne i casi estremi di solito relativi a sette, come il recente caso della bimba australiana privata delle cure mediche a favore della preghiera che avrebbe dovuto guarirla o resuscitarla.
E vado ancora oltre: sono convinto che, da sempre, soprattutto chi racconta quella storia è il primo a non crederci. Si alimenta il sistema che c’è dietro e che garantisce enormi vantaggi di vari generi, in cambio bisogna solo recitare qualche formula, fare qualche gesto con le mani, continuare a raccontare la stessa storia difendendola come si può dallo spirito critico.
Papa ateo? Sì, ne sono convinto. Da sempre. Anche tutto il resto dell’ alto clero, magari giusto il preticello di una comunità da dieci anime fa sul serio e, magari, viene pure ostracizzato dalla stessa chiesa per aver dato priorità al bisognoso piuttosto che all’ interesse del sistema di cui fa parte.
Il giorno in cui dovesse essere inventato un sistema per leggere il pensiero (ipotesi per assurdo), per le religioni sarebbe la morte immediata.
Ciao Giovanni,
grazie per il tuo commento.
Ho trovato motlo interessante il tuo spunto sul Papa Ateo cosa che ho sempre pensato anche io e credo che la forza della Chiesa sia proprio quello: mantenere vivo lo spettacolo nonostante tutto. Salimbene da Parma (lo racconta Barbero) riferì di aver conosciuto un Vescovo ateo che in punto di morte rifiutò i sacramenti dicendo che non ci credeva e che aveva fatto il Vescovo per le ricchezze e per gli onori, naturalmente.
Ciao Fabrizio,
innazitutto grazie per il commento e per la pazienza usata nel leggere il testo.
Non ho molto da aggiungere a quanto hai detto tranne che a me in quanto essere umano limitato sarebbe bastato avere un manufatto completamente estraneo alla nostra comprensione , per alleggerire, immaginati una bibbia che emetta suoni e raggi di luce o che muti forma incarnando la storia che racconta; ecco ciò sarebbe un qualcosa di straordinario al di fuori della nostra realtà che creerebbe problemi agli atei o ai non credenti in generale. Oppure se i contenuti fossero assolutamente predittivi con nomi e cognomi, date precise, spiegazioni di tecnlogie future esattamente spiegate allora…
Di sicuro un libro (o pergamente o qualsiasi cosa) scritto in una lingua umana, corente con gli usi e costumi umani del tempo in cui fu realizzato, contente tematiche coerenti alla’età del ferro o del bronzo o all’età calssica, onestamente convince poco. Stessa cosa per quelli che dicono che le Piramidi siano state fatte da chissà chi: alla fine dei conti sono degli enormi triangoli di pietra poggiati per terra. Se flutturassero in cielo contrastando la gravità ci faremmo tutti due domande, ma viste così non mi sembrano nulla di trascendentale.
Un saluto,
Dario
Assolutamente d’accordo. Aggiungerei che l’idea stessa di Dio che sceglie il linguaggio umano per rivelare se stesso all’umanità è di per sè problematica, proprio per tutte le ragioni che tu hai elencato. Il linguaggio è condivisione di significati, è interpretazione. Non è conoscenza immediata. Il fatto che lo stesso messaggio cristiano (o ebraico o islamico) sia stato ed è tutt’ora oggetto di innumerevoli interpretazioni contrastanti che hanno avuto come conseguenza una considerevole quantità di atrocità testimonia l’altissimo grado di incertezza che un simile mezzo di trasmissione di conoscenza comporta. In altre parole, un Dio desideroso di comunicarsi agli uomini avrebbe potuto optare per altre modalità più immediate. L’obiezione del credente è che ciò avrebbe compromesso la nostra libertà e l’esigenza della fede stessa, ma questo contraddice la dottrina per cui esseri spirituali come gli angeli che avevano la visione immediata di Dio hanno scelto di voltargli le spalle, per cui hanno potuto esercitare la loro libertà. Inoltre, partendo dal presupposto che l’intenzione di Dio nel creare è quella di donare la felicità alle sue creature, non è ragionevole pensare che un metodo di autorivelazione più immediato sarebbe stato più adatto allo scopo?
Bella riflessione! Io penso che nel momento in cui un Dio si rivela a tutti ,il gioco esistenziale finisce per l’uomo che per sua natura è curioso ma sente nel proprio inconscio di far parte di un disegno cosmologico più grande che al momento non può spiegare e lo ripiega nelle varie religioni, che guarda caso hanno quasi tutte in comune un aldilà.È proprio il mistero della vita a tenerlo attivo cerebralmente.
Sul fatto che anche gli angeli abbiano voltato le spalle a Dio essere perfetto ,mancano molti riferimenti di comprensione ma non mi stupirei che lo scherzo tirato sia più o meno quello fatto ad Adamo ed Eva, cioè avvisati di una conseguenza senza aver capito cosa sia questa conseguenza ,oppure che le conseguenze siano state comprese bene ma si è deciso comunque di fare di volonta propria .
ciao MrRobot,
grazie per il tuo spunto.
Dario